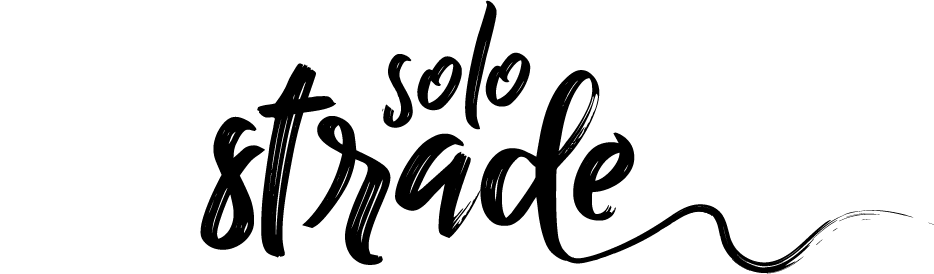Circa 4000 anni fa, quando ancora si chiamava Tebe, Luxor era la capitale dell’Egitto. Non si sceglie una capitale per caso: in quel momento storico gli Egizi la elevarono a punto di riferimento, scegliendola come fulcro della loro civiltà per la sua posizione strategica, per il suo ruolo di crocevia tra culture diverse, per le sue costruzioni. Parlando di edifici, la città moderna pullula di rovine di antichi templi, molti dei quali in condizioni quasi perfette; anche per questo motivo, Luxor è stata spesso definita come “il più grande museo aperto al mondo”. La prima opera d’arte incontrata giace a pochi metri dalla riva destra del Nilo, e lascia senza fiato: è il tempio di Luxor, al cui ingresso si stagliano sei grosse statue e un obelisco che tende verso il cielo. Dopo averne varcato la soglia, il passo successivo è proseguire attraverso il maestoso colonnato di Amenhotep III.

La serie di sette coppie di imponenti colonne decorate traccia il percorso incanalando, oggi come allora, il flusso di persone verso un grande cortile delimitato interamente da schiere di altre colonne, che si frappongono tra il cortile stesso e il santuario del tempio. L’effetto dato dalla disposizione dei grossi pilastri fa sì che l’osservatore percepisca questo spazio come se fosse più grande di ciò che realmente è, evidenziando l’idea di infinito e mistero, caratteristiche tipiche delle divinità che, teoricamente, si celerebbero nelle retrovie del tempio.


Sulla riva destra del Nilo si trova anche il gigantesco complesso templare di Karnak, aggiornato e modificato da ogni Faraone nel corso degli anni. Vengo accolto all’ingresso da una sequenza di statue, che introduce a un enorme colonnato, possibilmente più imponente di quello visto in precedenza. Col senno di poi credo che, per visitare nel dettaglio questo tempio enorme, per godere dei suoi particolari e delle sue geometrie, mi sarebbero serviti almeno quattro giorni, e così ho cercato di fare in un pomeriggio qualcosa che avrebbe richiesto sicuramente più tempo. Era però arrivato il momento di attraversare il fiume abbandonando la East Bank, vale a dire il lato del Nilo scelto in passato per venerare gli dei ma soprattutto per celebrare la vita, in direzione della sponda occidentale, luogo dove gli Egizi decisero di erigere le tombe per i loro faraoni. In poche parole, lo scopo era quello di raggiungere l’Aldilà a bordo di un’imbarcazione.


Una volta raggiunta la sponda occidentale inizio a camminare e, nel mio viaggio verso una delle varie necropoli, incontro un uomo seduto su una collinetta. Si chiama Ahmed, ha 54 anni e fa il tagliapietre. E lo fa a mano, usando una normalissima sega. Divide blocchi di marmo in pezzi più piccoli che verranno poi ulteriormente lavorati. Tutto il giorno: gli portano le pietre e lui, seduto per terra su una collinetta, taglia. In mezzo ai sassi e alla polvere, lui taglia. Sotto il sole, un caldo micidiale, e lui taglia. Mi dice di avvicinarmi e mi mostra le sue mani, ricoperte di calli e ferite. E me le mostra in maniera orgogliosa e stanca al tempo stesso, con la consapevolezza di chi sa che senza dubbio potrebbe andare meglio ma, al contempo, si ritiene fortunato per ciò che ha.

Il viaggio continua fino a raggiungere un piccolo ingresso di pietra, alle spalle del quale si erge maestoso il tempio funerario di Ramses III conosciuto come Medinet Habu. È un complesso enorme, quasi sconfinato, la cui facciata principale, decorata da incisioni che si estendono su tutta la sua superficie, ti fa sentire piccolo, spaesato, fuori posto. E in effetti un po’ fuori luogo lo si è, essendo la sponda occidentale riservata all’Aldilà. Ma la cosa che più mi ha stupito l’ho trovata all’interno: oltre alle rovine di vecchi porticati e numerose statue di Ramses, molte delle colonne portanti conservano ancora i colori con cui erano state dipinte. Lasciandomi trasportare dalla fantasia, provo a immaginare quel gigantesco sito completamente colorato, pensando alla magia a cui si trovavano di fronte i fortunati che potevano accedere al tempio, quando ancora i pigmenti erano saldamente attaccati alle pareti e il tempo non ne aveva soffiato via la brillantezza.


All’alba dell’ultimo giorno, mi reco presso un gigantesco spiazzo polveroso su cui sono adagiati degli enormi teli colorati e, a fianco a ciascuno di questi, una specie di grossa scatola di vimini. Ed è proprio in una di queste ceste che sarei entrato, per godere delle bellezze di Luxor anche dall’alto. Ma nonostante la prospettiva di volare sopra la sterminata e desertica Valle dei Re, di far perdere il mio sguardo tra le migliaia di campi che crescono rigogliosi ai lati del Nilo, di planare sulle numerose rovine e sul confine che divide la sponda dei vivi da quella dei defunti, c’era un piccolo particolare di cui (non) avevo tenuto conto. Dicono che bisogna affrontare le proprie paure per vincerle, che si deve provare di volta in volta a superare i propri limiti. Penso che, per uno che soffre di vertigini, salire su una mongolfiera e fluttuare a 1600 metri d’altezza sia un buon punto di partenza.